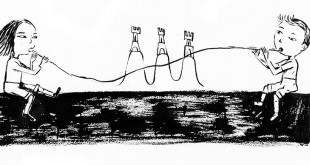Ho lo spazio di tre minuti per regalare un fiore
di Silvia Marigonda
Ho lo spazio di tre minuti per regalare un fiore. Il tempo fra un treno e l’altro della metropolitana, quando la gente aspetta, carica di stanchezza per quanto è stato, di speranza per quello che sarà.
Tengo d’occhio il tabellone dell’orario e in quei tre minuti incontro la ragazza china sul suo cellulare, che si scosta di continuo i capelli dal viso e l’uomo che al telefono parla a voce troppo alta, stringendo a sé lo zaino di pelle nera. Alcuni non mi guardano neppure, altri con indifferenza mi danno una moneta per portarsi a casa una delle mie rose.
Io sono sempre lì, non ci sono stagioni al binario della linea 1 della metropolitana. Mi copro la bocca con una piccola sciarpa lilla, fa freddo là sotto anche d’estate quando sta per arrivare il treno.
Non è sempre stata così la mia vita.
Quando c’era Augusto, io tenevo in ordine la casa e cucinavo per lui e per i nostri figli. Gli preparavo le lasagne con il ragù, e qualche volta anche l’arrosto seguendo la ricetta che mi ero scritta sul quaderno bisunto.
Quando, nel pomeriggio, Augusto tornava dal cantiere, andavamo a passeggiare lungo il canale dietro casa: fatti bella solo per me mi diceva con una carezza, ed io indossavo il filo di perle preso con i punti della spesa. Augusto non parlava tanto, ma teneva stretta la mia mano e si chinava a raccoglieva dei ranuncoli o dei non ti scordar di me.
A casa, li mettevo in un vasetto di vetro riempito d’acqua che tenevo sopra la mensola in cucina. Quando li guardavo, durante il giorno, pensavo a mio marito e alla nostra vita, a quando ci eravamo conosciuti da bambini, e poi sposati nella piccola chiesa del paese, con i nostri genitori e qualche amico e non avevamo niente ma lui lavorava sodo, e poi erano arrivati i ragazzi e adesso riuscivamo anche a passare le vacanze d’agosto in Trentino nella pensione Ada, dove ormai ci consideravano di famiglia.
Quel giorno stavo cambiando l’acqua del vasetto, non volevo che i ranuncoli si seccassero troppo presto, quando mi sfuggì di mano e accidenti, pensai, non mi cade mai niente e invece questo si era rotto in mille frammenti che scintillavano in una piccola pozza sul pavimento di piastrelle verdi. Mi ero fermata a fissarli, come abbagliata da tanti piccoli diamanti.
Così non avevo sentito subito il telefono e dopo avevo risposto in fretta per paura di perdere la chiamata e tutto mi era parso così confuso: il montacarichi, nulla da fare, ci dispiace signora.
Non so chi quel giorno raccolse da terra i pezzi del vasetto caduto, forse restarono lì a brillare anche nei giorni successivi, ma sono certa che nessuno fu capace di raccogliere i pezzi che avevo dentro quando deposi un mazzetto di ranuncoli sulla bara di Augusto, là nella chiesa gremita di volti che in gran parte non conoscevo.
Un fiore e una moneta, mi torna sempre in mente qua sotto la metro, perché le spese per il funerale furono sole le prima di una lunga serie. Mi arrangiai come potevo, non tanto per me, perché oramai mi bastava davvero poco, ma perché c’erano i figli da far studiare e io non avevo più tempo per andare lungo il canale la sera.
Poi arrivarono le ruspe e lo interrarono, al suo posto dei muratori che parlavano una lingua a me sconosciuta costruirono enormi palazzi e io ci rimasi un po’ male, perché anche se non ero più tornata, ricordavo le passeggiate con Augusto e lui che diceva che quello che davvero un uomo ha dentro è come un corso d’acqua: puoi coprirlo, ma troverà sempre la sua via per uscire.
Io non avevo più niente dentro di me e, quando i ragazzi se ne andarono per la loro strada, uno in Germania e l’altro a lavorare in un’altra città, mi sedevo nel nostro salotto per interi pomeriggi e guardavo la polvere danzare nella luce di una pallida primavera, che poi lasciò spazio ad un’estate soffocante.
Poi ci fu la pioggia, così abbondante che i giornalisti facevano a gara per fornire le loro statistiche: dissero che era la pioggia più abbondante degli ultimi cento anni, ma non lo so se era vero, perché anche quando ero una bambina i miei nonni raccontavano della pioggia che non smetteva mai.
Di quella notte ricordo solo che nel mio sogno il canale era tornato, perché potevo sentire il rumore dell’acqua che lentamente riprendeva a scorrere e anche Augusto era tornato a passeggiare con me, senza dire nulla, solo tenendomi la mano nella penombra della sera che scivolava verso la notte.
Il mattino dopo, quando mi svegliai, il canale c’era davvero: si era fatto strada tra il fango e le macerie. Ricordo che tutto appariva livido e freddo, e che qualcuno piangeva.
Dissero che lì non si poteva più abitare perché c’era il canale, e io rimasi sorpresa, perché con Augusto e i nostri figli lì avevamo trascorso tutta la nostra vita insieme senza che nessuno ci dicesse niente e anche noi non avevamo mai avuto paura.
Dopo poco mi assegnarono un minuscolo appartamento in un condominio della periferia. Lì non c’erano ranuncoli e nemmeno la polvere che danzava nella luce. Pensai che forse Augusto era rimasto nella nostra vecchia casa, perché non lo sognai più, solo faticavo per riuscire a comprarmi quanto bastava per il pranzo e per la cena.
Tanta gente viveva nel mio palazzo e anche in quelli vicini, ma pensai che che tutti avessero paura di qualcosa, perché quando li si incrociava acceleravano il passo.
Si udivano i rumori delle auto, dei treni della ferrovia poco lontana, ma si sentiva assai di rado qualcuno parlare. Pensai che quanto maggiore è il rumore cittadino, tanto più si spengono le voci delle persone.
I ragazzi mi telefonavano a Natale e poi per il mio compleanno, ma la linea a volte era disturbata o dovevano correre al lavoro o a prendere i bambini a scuola. Non conoscevo i miei nipoti, e pensavo fosse meglio così, perché in quel mondo incolore e spoglio che era ormai il mio, il chiacchiericcio di un bambino non avrebbe trovato posto.
Poi un giorno, all’angolo della piazza comparve una bancarella nuova. Il proprietario aveva la pelle scura, si capiva che veniva da un paese lontano: forse laggiù c’erano fiori diversi da quelli che vendeva qui, pensai, forse i loro colori erano più intensi, i petali più grandi, eppure con quanta cura accarezzava le nostre rose, i gladioli, gli Iris blu come un cielo che avevo dimenticato.
Una mattina, non lo so perché proprio quella mattina, perché non aveva niente di diverso dalle altre, una mattina, dunque, scesi nella piazza e, senza pensarci su, diedi all’uomo gran parte dei miei risparmi. Poi presi così tanti fiori da riempirmi le braccia.
Erano tulipani, giacinti, begonie e io li strinsi forte, come se ci fosse di nuovo Augusto lì con me, e tutto quello che non avevo più.
Il loro profumo ebbe davvero il potere di riportarmi alla vita, ma non quella con Augusto, che per sempre sarebbe rimasta custodita nel mio cuore, ma una tutta nuova, in cui avrei trascorso le mie giornate a donare fiori ai viaggiatori, nei tre minuti di tempo fra un treno e l’altro, perché potessero avere un piccolo vasetto pieno d’acqua e fiori colorati, sulla mensola della loro cucina.
Io mi chiamo Elvina e copro la mia bocca con una piccola sciarpa viola, regalando fiori tutti i giorni al binario della linea 1 nella metropolitana di Milano.
 Zoomma Dove scoprire nuovi interessi
Zoomma Dove scoprire nuovi interessi