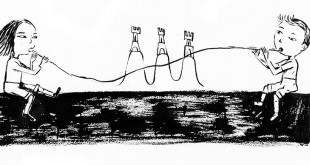Bellamossa e l’Aurelia
Tutti lo conoscevano come “Bellamossa”. In realtà si chiamava Benito e dov’era nato, nella valle al di là della montagna, era conosciuto come Gigante, ma tutti lo dicevano senza farsi sentire. Lo chiamavano così perché era alto 1.55, e il motivo per cui nessuno si faceva sentire a chiamarlo Gigante era perché Benito aveva un gran brutto carattere e non si vergognava a lavorare di coltello, all’occorrenza. Era nato a pochi chilometri di distanza, ma quando cominciò a frequentare il paese, disse di essere sardo. Forse perché era piccolo e di carattere, così come si diceva fossero i sardi. Forse. Ma c’era un motivo più particolare per cui si era inventato natali isolani: e questo motivo si chiamava Aurelia.
L’Aurelia era una gran bella ragazza. Bionda e formosa, con un culo grande ma sodo, che sapeva dimenare magistralmente a destra e a manca quando passava per strada. Era ammirata da tutti e i ragazzi del paese facevano la fila per corteggiarla, ma lei rifiutava sempre sdegnata. Lei andava matta per i sardi, diceva. Quelli erano veri uomini, il resto non contava. In realtà, di sardi ne aveva conosciuto soltanto uno nella sua vita, qualche anno prima: Bepi, un moro ricciuto dalle sopracciglia folte come cespugli, le mani grandi e le gambe storte. Bepi faceva il militare nella città vicina e l’Aurelia lo aveva conosciuto una sera, durante la processione del Santo Patrono. Bepi era in libera uscita, seduto davanti al bar con alcuni commilitoni. L’Aurelia, che partecipava alla processione, gli era sfilata davanti come una madonna; un po’ in carne, sì, ma il velo azzurro e gli occhi cerulei avevano dato al ragazzo quella impressione. Si era alzato e si era unito alla lenta, cantilenante, marcia. L’Aurelia, dal canto suo, non aveva mai smesso di voltarsi, sentendo alle spalle il passo marziale di quel militare con cui aveva incrociato lo sguardo.
Dalla prima parola scambiata al fatale innamoramento era passato ben poco. L’Aurelia era rimasta affascinata e colpita da Bepi, dalle sue mani forti, dalla sua carnagione scura, dai suoi modi ruvidi ma eleganti al tempo stesso. E Bepi si sentiva ribollire il sangue, alla vista di tutto quel ben di dio che l’Aurelia sapeva sfoggiare con povera ma dignitosa eleganza. In una notte di fine giugno si giurarono amore eterno e lei gli consentì di cogliere il suo fiore ancora fresco di rugiada. Lui lo colse non solo volentieri e con impeto, ma nella foga della passione pretese, e ottenne, pur con qualche ritrosia da parte della ragazza, di soddisfare ogni suo intimo desiderio, anche il più nascosto.
Il risultato fu che la poverina, empia di amore e di lussuria, dovette passare i due giorni successivi senza riuscire a sedersi, ma fu un sacrificio che sopportò volentieri.
Che impeto!
Che passione!
Che amor puro e incondizionato! Eterno!
Sì, Bepi sarebbe stato il suo uomo per tutta la vita. Questo pensava l’Aurelia mentre si apprestava a tornare in città per rivedere colui con cui presto, sperava, sarebbe salita all’altare. Ah, se i suoi genitori fossero stati ancora vivi, pensava ancora, persa in un sogno estatico. Le scese una lacrima al pensiero che né il padre né la madre l’avrebbero potuta vedere nel suo giorno più bello e più felice. Era sola al mondo, chi l’avrebbe accompagnata all’altare?
Spense la malinconia pensando che i genitori da lassù avrebbero visto lo stesso il coronamento di questo grande amore che niente e nessuno le avrebbe portato via.
Invece ci si mise di mezzo il destino, o meglio, il congedo, a portarglielo via, un mattino di inizio luglio.
L’Aurelia, appena giunta in città, si era precipitata davanti alla caserma e si era messa in paziente attesa dell’uscita dei militari. C’erano altre ragazze, come lei, ad aspettare la divisa giusta. Una ad una salutavano il soldato che apriva il portone e si avviavano mano nella mano a passeggiare. In breve l’Aurelia rimase sola. Attese un altro po’ poi si decise a chiedere informazioni al soldato di guardia nella garitta.
Ci volle una buona mezz’ora prima che un altro militare, che sfoggiava una specie di freccia gialla sulle spalline, le comunicasse che il soldato Piras Giuseppe si era congedato il giorno precedente ed era tornato nella sua terra.
-Ma… non è possibile!- Aveva piagnucolato l’Aurelia. -Non ha lasciato una lettera per me? Per il suo amore eterno?-
Non era sicura della risposta, ma le parve che l’uomo in divisa le avesse detto qualcosa tipo: nessuna lettera, mi dispiace. E, già che era lì, il sottufficiale ci aveva provato a consolare la procace ragazza, rimasto piacevolmente attratto dall’alternarsi ritmico del voluminoso petto durante i suoi singhiozzi. Il segno rosso delle dita gli rimase stampato sulla guancia pallida per tutta la giornata. Era una ragazza di carattere, l’Aurelia.
Da quel giorno non aveva più voluto sentire di altri uomini. Il ricordo del suo Bepi, le sue mani, i suoi baci e soprattutto l’impeto del suo amore era troppo forte e pressante. Diceva che solo un altro come lui avrebbe potuto conquistarla. Un altro sardo, perché, diceva, i sardi sono veri uomini. Gli unici.
La prima volta che Benito vide l’Aurelia fu quando in città arrivò il luna park. Un avvenimento che attirò gente da tutti i paesi vicini, compresi quelli in cui vivevano anche i due giovani. Benito stava camminando in mezzo a due suoi amici; a vederli sembravano formare una M, visto che gli altri due erano parecchio più alti di lui. Benito si controllava le scarpe, imbiancate dalla polvere della ghiaia sulla quale stavano passeggiando.
-Bellamossa! Guarda là che schifo. E le ho pulite prima di venire in questo schifo di posto!-
Fu mentre alzò il mento per cercare conforto nelle espressioni degli amici, che il suo sguardo rimase impigliato, invece, nella figura che si trovò davanti. Era l’Aurelia, bella e sorridente, con in mano un vaporosa nuvola di zucchero filato in cui stava beatamente affondando le labbra. Benito rimase fulminato all’istante, tanto che, automaticamente appoggiò le scarpe sui pantaloni di Ermanno, uno dei suoi amici, strofinandole sul panno chiaro per pulirle, mentre non staccava gli occhi dalla paradisiaca visione che gli era apparsa.
-Ehi, che fai?- Ermanno ritrasse la gamba infastidito. -Sei impazzito? E’ l’unico paio di pantaloni buoni che ho.-
Ma Benito non lo sentì nemmeno. Continuava a puntare con sguardo ferino le forme procaci della ragazza bionda.
-Benito! Ci sei? Ma che ti è successo?- Entrambi guardarono nella stessa direzione.
-Ehi, ma quella è l’Aurelia- disse Remo, l’altro amico.
Benito scattò come una molla. Improvvisamente sembrava diventato più alto del suo amico. Le sue braccia lunghe e scimmiesche si arrampicarono sulla camicia di Remo e l’afferrarono per il bavero.
-Vuoi dire che conosci quella là?- masticò.
-Ohhh e lasciami, che sei impazzito?-
Benito mollò la presa, anzi, con le mani fece il gesto di spazzolare la giacca all’amico, che lo allontanò con un gesto.
-Parola mia, tu sei fuori di testa. Comunque sì, certo che la conosco. Non la vedevo da qualche anno ma so bene chi è.-
-Bellamossa!- Esclamò soddisfatto Benito.
Remo aveva fatto il militare nella stessa caserma di Bepi il sardo. Anzi, erano amici; lui era di uno scaglione seguente al suo, per cui si ricordava bene il congedo del sardo e quella ragazza bionda che era venuta poi a cercarlo. Anzi, rimestando nella memoria, Remo si ricordò della sera in cui si erano conosciuti, di come Bepi aveva lasciato il tavolo del bar e si era messo in processione. E poi tutto il resto. Raccontò la vicenda ai due amici, che ascoltavano in silenzio. Benito intanto non perdeva con lo sguardo tutto ciò che faceva l’Aurelia. Ora stava ridendo sulla giostra dei cavalli e lui aspettava trepidante di vedere spuntare quello bianco su cui era salita lei.
Remo intanto continuava a raccontare. Aveva saputo di come l’Aurelia fosse rimasta fedele al ricordo del suo amore sardo e di come non avesse più voluto saperne di altri uomini. Raccontò di quanto lei andava dicendo: e cioè che l’unico uomo che avrebbe potuto di nuovo conquistarla non avrebbe potuto che essere sardo.
-Insomma, uno basso, scuro di pelle e dal coltello facile- rise Ermanno. -Sono tutti così i sardi, no?-
Benito si diede un’occhiata. Basso lo era, dal coltello facile lo stesso. La pelle era maledettamente bianca, ma a quello si poteva rimediare.
-Bellamossa- Pensò.
Si alzò per dirigersi verso la giostra, ma proprio in quel momento si accorse che l’Aurelia non era più là. Si guardò intorno muovendo furiosamente il collo piccolo e nervoso. Dove cazzo era andata? Cominciò ad agitarsi, a cercare in ogni direzione, muovendosi a scatti. Gli amici si avvicinarono sorpresi.
-Che cazzo fai Benito?-
Niente. Era sparita. Si era distratto per pochi secondi e quelli erano bastati alla ragazza per confondersi nella folla. Proprio come una dea, pensò Benito, chiedendosi subito dopo se le dee avessero fra le loro caratteristiche quella di scomparire. Cancellò il pensiero e si rimise a cercare fra la gente. Niente da fare. Non riuscì a localizzare il maestoso culo dell’Aurelia, che, era certo, avrebbe riconosciuto all’istante. Si voltò verso Remo fulminandolo con gli occhi.
-Sai dove vive quella ragazza?
-Sì- Rispose perplesso l’amico.
-Bellamossa!- Sogghignò Benito.
Qualche giorno dopo, in paese arrivò un ragazzo basso, con i capelli nerissimi, le braccia lunghe, le mani pelose e dotato di una forza eccezionale. Si chiamava Benito, diceva di essere sardo e di essersi trasferito in quella zona da poco. Cercava lavoro come manovale o come fabbro. Un lavoro di fatica, insomma. Passava le serate al bar, era un gran bevitore e abusava sempre di un intercalare che gli valse il suo soprannome: Bellamossa.
Il piano di Benito era semplice: non doveva essere lui ad andare a cercare l’Aurelia (anche se, ogni volta che scendeva in strada, occhiava attentamente a destra e a manca nella speranza di posare lo sguardo su quel culo che gli si era appeso alla mente come un quadro a una parete) ma voleva che fosse lei a sapere della presenza di un sardo in paese, così si sarebbe fatta avanti. Sarebbe stato tutto semplice, non doveva sembrare un piano per conquistarla. Remo lo aveva informato che altri, prima di lui, si erano finti sardi ed erano andati a cercarla, ma lei aveva sempre capito l’inganno e li aveva cacciati a sganassoni. Le piaceva anche il carattere di quella Giunone. Ma a lui non sarebbe successo così. Lui era sardo, era appena arrivato e non sapeva nulla di questa ragazza così attratta dagli uomini della sua terra. Così era perfetto. Ne era convinto e, come diceva sempre Remo, per convincere gli altri di qualcosa bisogna prima esserne convinti noi stessi.
Ermanno, che aveva uno zio di Sassari e che una volta era venuto a trovare i parenti, gli fece un corso intensivo sulla parlata sarda.
-A scatti, ricorda, parla a scatti e chiudi le o.-
-E poi?-
-E poi… boh? Non sono mica io, il sardo!-
-Ma avrai sentito parlare i parenti, no?-
-Ero piccolo, Benito. Ti dico quello che ricordo. Ah… un’altra cosa. Mettono la U dappertutto. Tu, ogni tanto, fai finire una parola per U.-
-Per U?-
-Per me siete cretini- interruppe Remo.
-Tu sta’ zitto!- Lo fulminò Ermanno. -Vuoi insegnargli tu come parlano i sardi?-
-M’importa assai a me. Mi pare tutta una gran canata questa qua-. Benito, furioso, gli saltò addosso, minacciandolo con la mano aperta a pochi centimetri dal viso.
-Ohè Remo! Non mi far dimenticare che siamo amici eh?-
-Va bene, va bene- chiuse Remo. -Non parlo più, sei contento?-
Benito si sistemò la camicia soddisfatto. -Sì, contentu!- Cercò approvazione nello sguardo di Ermanno, che gli mostrò il pollice alzato.
-Bene. Vi farò sapere, ragazzi!-
Aveva inforcato la bicicletta e si era allontanato.
L’inizio non fu dei migliori. Benito sapeva che in un paesino piccolo le notizie si vengono a sapere alla svelta, per cui, la prima sera, dopo essersi sistemato nella stanzina che aveva preso in affitto, si presentò all’osteria del paese ed entrò trionfalmente, con un sorriso da pubblicità, agitando quelle sue braccia lunghissime.
-Buonaseru!- Cinguettò.
Si voltarono tutti, guardandolo come si può guardare qualcosa di inanimato, tipo un palo, che improvvisamente si mette a correre.
-Chi è quello scimpanzè?- Disse uno, ma lo disse troppo forte tanto da farsi sentire anche dal nuovo entrato.
Un’ora dopo, Benito era seduto a testa bassa davanti al maresciallo Calindri, nel vicino capoluogo. Il maresciallo lo aveva fatto portare nel suo ufficio dai due carabinieri che erano intervenuti a sedare la rissa scoppiata nell’osteria del paese vicino. Appena entrato, Benito aveva abbassato occhi, orecchie, testa… tutto, insomma e si era messo seduto e zitto di fronte al militare, che lo guardava senza dire una parola.
Passarono così dieci minuti buoni, con Benito che non emetteva alcun suono, se non qualche sonoro deglutio. Il maresciallo ticchettava la matita sulla scrivania in legno scuro.
-Benito!- Ruppe il silenzio bruscamente. Conosceva bene quel giovane e le sue intemperanze.
-Maresciallo…- sussurrò lui alzando lievemente gli occhi senza muovere la testa.
Benito raccontò tutto al maresciallo. Senza staccare lo sguardo da terra, con le mani incrociate alle ginocchia, il ragazzo si confessò candidamente, sospirando ogni volta che pronunciava il nome dell’Aurelia. Il maresciallo accese un sigaro e sollevò una gamba piegandola sopra l’altra. Sbuffi di fumo si alternavano ai suoi pensieri. Benito, terminato il racconto, sollevò di nuovo gli occhi e si preparò in silenzio alla sentenza.
Il maresciallo Calindri si ricordò di quando, da giovane, aveva dovuto fingersi un poeta per conquistare Benedetta, colei che sarebbe poi diventata sua moglie. Un poeta! Lui che non aveva mai letto una poesia in vita sua! Per fortuna c’era Armando, suo cugino, l’intellettuale di famiglia, che gli aveva parlato di un romanzo francese: Cyrano de Bergerac. Gli aveva raccontato tutta la trama e il giovane Calindri si era entusiasmato. Così avevano approntato il piano, in cui lui avrebbe recitato a Benedetta le poesie scritte da Armando. Per sua fortuna, Benedetta, oltre che ragazza colta e di buone maniere, aveva anche un’intelligenza vivida e uno spiccato senso dell’umorismo, per cui aveva capito subito tutto: non se l’era presa di fronte alle orribili poesie di seconda mano, che, aveva subito capito, non erano comunque scritte dallo spasimante, e aveva in ogni caso apprezzato lo sforzo del Calindri. Quindi gli aveva concesso di corteggiarla. Ma senza poesie, per carità: non bisogna essere uguali in tutto nella vita. Così aveva sentenziato la futura signora Calindri.
Fu il maresciallo stesso che riaccompagnò Benito in paese e, giunti all’osteria, convinse l’aggredito a ritirare la denuncia. Spiegò che il ragazzo veniva da lontano, da un’altra terra, era appena arrivato, insomma… per questa volta ci sarebbero passati tutti di sopra, ok? Gli astanti annuirono all’unisono. Benito era diventato uno di loro.
-E quella storia delle U… fammi il piacere Benito. Parla il meno possibile e non esagerare.- Gli aveva detto durante il tragitto in macchina verso il paese. Benito aveva annuito, annotandosi mentalmente di rompere i denti a Ermanno, non appena gli avesse messo le mani addosso.
-E ricorda che ti tengo d’occhio! Alla prossima cazzata non te la cavi- chiosò Calindri all’esterno dell’osteria, dopo che gli animi furono placati. Benito annuì di nuovo. Doveva tenere a freno quel suo carattere irruento. Sì, ce l’avrebbe fatta. Per lo scopo che si era prefisso.
Ringraziò il maresciallo con inchini deferenti e quasi gli scappava persino un baciamano. Calindri ritrasse la mano e gli ammollò un buffetto.
-Vai sardo… e in bocca al lupo!- E ripartì.
Così Benito si trovò inserito nella vita del paese. Cominciò a frequentare l’osteria, a dimostrare doti di ottimo bevitore e giocatore di carte. Trovò lavoro anche come manovale presso uno dei tizi che frequentavano l’osteria. Riuscì perfino ad accettare e digerire il nomignolo che gli avevano messo: “Bellamossa”. Dopotutto non riusciva a fare a meno di quell’intercalare, quindi… anche se non era contento di sentirsi chiamare così, fece buon viso a cattiva sorte. Non doveva rimettersi nei guai. Per l’Aurelia.
L’Aurelia. Già. Erano passate due settimane da quando Benito stava in paese, ma non era ancora riuscito a scorgerla. Non voleva fare domande a nessuno, nessuno doveva sapere lo scopo della sua presenza lì. Sicuramente si era già sparsa la voce che un sardo era arrivato in paese, perché l’Aurelia non era ancora saltata fuori? Ormai viveva con lo stomaco ribaltato, ogni giorno lavorare era diventato sempre più pesante. Stava sempre con lo sguardo attento, pronto a cogliere il passaggio della sua bella, ma fino a quel momento… niente.
Il sabato sera era stata organizzata una festa nella sala della parrocchia. Pur non avendo troppa simpatia per i preti, Benito decise di andarci. Sicuramente ci sarebbe stata anche lei. Si vestì di tutto punto e si presentò nella sala. Era pieno di giovani e anche meno giovani. I suoi occhietti balenarono velocemente per ogni dove, ma non c’era presenza dell’Aurelia. C’erano molte ragazze, alcune anche belle, ma nessuna traccia di colei che lo aveva trafitto al cuore. Si mise a sedere sconsolato e lì passò tutta la serata, senza nemmeno la voglia di bersi un bicchiere di vino.
-Bellamossa, che ci fai lì tutto solo? Ma che non ti piacciono le donne? Sarai mica uno di quelli eh?- Ghignò una voce a pochi passi. Benito si alzò di scatto con il pugno chiuso, pronto a spaccare il naso al portatore di quella voce. Se lo vide davanti con il sorriso su quella faccia da scemo e stava per colpire, quando, nella mente gli si sovrapposero le immagini dell’Aurelia e del maresciallo Calindri. Gonfiò il petto riempiendolo di aria e di rabbia, aprì il pugno e alzò gli occhi al cielo, bestemmiando mentalmente. Poi uscì dalla sala e si precipitò a dormire.
Ma che mi sta succedendo? Pensava. Questo non sono io, non posso andare avanti a lungo così. Dove cazzo si è rifugiata quella? Stai a vedere che non abita nemmeno qui. Se così fosse stato, Remo poteva pure cominciare a scavarsi la fossa. Ma la domanda rimaneva: dove era l’Aurelia? Avrebbe dovuto cominciare a chiedere in giro?
Quello che Benito non poteva sapere era che l’Aurelia, in quei giorni, se ne era andata in villeggiatura. Che poi, per lei non era proprio una villeggiatura, anzi.
L’Aurelia aveva perduto il padre quando ancora non aveva imparato a parlare e anche la madre se ne era andata presto. Aveva dodici anni quando era rimasta sola al mondo. Allora era stata presa a servizio nella villa della marchesa Monari-Serenini, dove già lavorava sua madre. La marchesa le aveva concesso di occupare una stanza nell’ala della servitù della villa e da quel momento l’Aurelia era diventata una delle sue donne di servizio. E anche qualcosa in più; dopotutto la marchesa Monari-Serenini era una donna di buon cuore e aveva preso a ben volere quella ragazzina e, in pochi anni, le aveva concesso di essere la sua cameriera personale, nonchè confidente. Non l’avrebbe mai ammesso, la marchesa, ma l’Aurelia per lei, era quella figlia che non aveva mai avuto, nonostante il suo passato piuttosto burrascoso dal punto di vista sessuale e sentimentale. Sì, perché la marchesa, ormai in avanti negli anni, vantava dei trascorsi notevoli. L’Aurelia aveva raccolto negli anni i racconti piccanti della movimentata vita sessuale della marchesa: la Monari-Serenini vantava fra i suoi (così, almeno, diceva) innumerevoli amanti anche un Re, tre premi Nobel e due cardinali. Più tutto il resto, naturalmente.
Si era anche occupata dell’educazione sessuale dell’Aurelia, instradandola verso sani princìpi libertini. Ma finora la sua era stata una delusione: che lei sapesse, le grazie della fanciulla erano ancora intonse. L’Aurelia si era vergognata di raccontarle la storia di Bepi e della sua passione per i sardi e la marchesa, che viveva isolata nella sua villa, lontana dalla vox populi, non aveva mai saputo niente di quella vicenda. Per cui viveva come una sconfitta personale la ritrosia che l’Aurelia mostrava verso gli uomini e il modo con cui cercava sempre di evitare l’argomento.
La marchesa Monari-Serenini aveva scelto quella villa sulla collina sopra il paese come suo buon ritiro (iniziato, per la verità quando non aveva ancora compiuto cinquanta anni, ma si sa, i nobili tendono alla pigrizia) ma possedeva anche molti altri possedimenti, fra cui una villa sul lago incastonato nella vicina montagna. La contessa amava passare parte del periodo estivo in quella villa, quando il lago si colorava di ricordi e di allegria. E naturalmente l’Aurelia era andata con lei. Proprio quando Benito aveva messo a punto il suo piano e si era presentato in paese. Ecco perché non l’aveva ancora vista. E quando Benito, ormai perduta la pazienza, stava per cedere ai suoi propositi e cominciare a chiedere in giro se la procace ragazza abitasse lì, l’Aurelia, a seguito della sua nobile padrona, fece il suo rientro.
Era lunedì mattina e Benito stava lavorando su un ponteggio insieme a un collega. Era nervoso e distratto, si era già rovesciato sui pantaloni la paiola del cemento e gli era caduto un mattone su un piede. Si era deciso a porre la domanda fatale, ormai non poteva più aspettare. Chiamò il collega e si avvicinò a lui.
-Che c’è Bellamossa?- Ma prima che Benito potesse parlare, l’uomo aveva spostato lo sguardo verso la strada e aveva alzato la mano in un saluto festoso.
-Ehilà, è tornata l’Aurelia! Ciao Aurelia!!-
La ragazza aveva risposto gioiosamente al saluto agitando a sua volta la mano in direzione del tetto da cui proveniva la voce.
Al sentire il nome dell’Aurelia gli occhi di Benito si sbarrarono, il cuore quasi gli esplose nel petto palpitando freneticamente, poi si fermò, poi ripartì sgommando; Benito fece in tempo a voltarsi verso la strada e a posare lo sguardo sull’oggetto dei suoi desideri, poi una combinazione di: cuore impazzito, gambe afflosciate, testa avvolta in un capogiro, schiena invasa dai brividi e braccia informicolite ebbe la meglio e il poveretto si trovò a precipitare dal ponteggio su cui stava lavorando. Il collega non potè fare altro di seguire il suo volo, prima di rendersi conto e precipitarsi a chiamare i soccorsi.
Per sua fortuna Benito aveva la pelle dura e le ossa non erano da meno, per cui nella caduta non si era fatto praticamente niente. Se ne stava sdraiato sul lettino nello studio del medico. Contusioni varie ma nessuna frattura, aveva sentenziato l’uomo in camice bianco. L’unica cosa che lo rendeva perplesso era lo stato catatonico di Benito, che gli faceva temere che potesse avere battuto la testa. Benito continuava a ripetere come una litania la stessa sillaba: la la la la la…
-Forse sta cantando!- Diagnosticò il collega che lavorava con lui sul ponteggio.
-Macchè- ribadì il dottore. -Temo che abbia battuto la testa e ci sia qualche problema neurologico-.
In realtà Benito cercava di pronunciare il nome dell’Aurelia ma si inceppava sempre dopo la prima sillaba per cui il suo l’A… l’A… l’A… non veniva compreso dagli astanti.
Intanto la notizia dell’incidente si era sparsa per il paese e i dettagli erano venuti anche all’orecchio dell’Aurelia: quel ragazzo arrivato da poco in paese, il sardo, era caduto da un ponteggio. “Poverino”. “Ma si è fatto male?” “Ben gli sta, non mi piace quello là”. “Com’è successo?” “Che ce li mandano a fare se non sanno stare in piedi?” E tutto il corollario di commenti vari, che avevano reso particolarmente frizzante quel lunedì mattina. Ma l’Aurelia aveva fissato la sua attenzione su un particolare: quel ragazzo era sardo. Che ci faceva un sardo in paese? Non poteva che essere lui, il suo Bepi. Finalmente era tornato a cercarla. La sua attesa non era stata vana, Bepi era tornato e ora l’avrebbe portata via con sè. Il suo cuore cominciò a correre come un cavallo all’ippodromo; non stava più nella pelle, cominciò a saltellare qua e là. Si stringeva le mani, si toccava i capelli, rideva e poi le veniva da piangere. Bepi. Bepi era là ed era là per lei. Poi improvvisamente si bloccò. E se invece non fosse stato lui? Un’ombra di angoscia le disegnò il bel volto. Cominciò a guardarsi attorno. Aveva bisogno di sapere.
-Come si chiama quel ragazzo sardo arrivato da poco?- La prima persona che l’Aurelia aveva identificato era Gino il bottaio, uno degli oracoli del paese. Gino si era fermato un attimo a studiare le forme della ragazza, immaginando in un secondo tutta una notte di scatenante lussuria, poi appoggiò le dita al mento.
-Si chiama Be…-
-Bepi!- Trionfò l’Aurelia con tono da soprano e coprendo il “nito” che si spense lentamente nella bocca di Gino. Felice come una pasqua, la ragazza corse via danzando sulla strada polverosa. Ma all’improvviso la sua euforia si placò. Accidenti… il “Bé” acuto pronunciato da Gino era diverso dal “Bè” gravemente accentato di Bepi. Quel suono diverso le era esploso all’improvviso in mente e le aveva gonfiato il petto d’angoscia. Riprese a guardarsi attorno. Aveva bisogno di chiederlo a un’altra persona. Avvistò la Serafina che stava tornando a casa con la sporta piena di ortaggi. La chiamò agitando la mano e corse verso di lei. Con affanno le rivolse la stessa domanda che aveva fatto a Gino il bottaio.
-Ma chi, Bè…-
-Bepi, Bepi- Raddoppiò l’Aurelia, stavolta convinta dal confortante accento della prima sillaba. “..llamossa” finì di pronunciare la Serafina, ma l’Aurelia era ormai lontana, rientrata nel suo mondo magico di danze e forme fluttuanti nell’aria.
Quando la ragazza entrò nello studio del medico, Benito si era appena alzato e aveva rassicurato sia il dottore che il collega: stava benissimo, non aveva battuto la testa ed era pronto a uscire e camminare con le sue gambe. In realtà avrebbe voluto spaccare la testa a tutti e due, che gli stavano fracassando i coglioni con la loro apprensione. Aveva voglia soltanto di correre dall’Aurelia e cercare il modo di approcciarsi a lei.
Se la trovò davanti, invece, quando lei spalancò la porta. Per un attimo rimasero tutti fermi, immobili, mentre gli occhi di ognuno correvano velocemente in ogni direzione. Benito si bloccò, le braccia distese lungo i fianchi. Sembrava davvero una scimmia, dal momento che quel mattino non si era nemmeno rasato. L’Aurelia scrutò attentamente i tre uomini nella stanza. Aveva la bocca aperta e respirava a fatica.
-Dov’è?- Chiese
-Dov’è chi?- Rispose calmo il dottore.
-Il ragazzo che è caduto dall’impalcatura-
Benito si voltò e notò che il dito del dottore indicava proprio lui. L’Aurelia si sentì mancare.
-Quello? Ma quello sgorbio non è il mio Bepi!- Piagnucolò. Ora le tremavano le gambe. Benito aprì la bocca ma non riuscì a emettere alcun suono. L’Aurelia lo squadrò ancora bene percorrendolo da capo a piedi e viceversa con un rapido sguardo.
-Come ti permetti tu di farmi pensare che il mio amore fosse tornato da me? E scommetto che non sei nemmeno sardo!-
Un secondo dopo, Benito era di nuovo sdraiato sul lettino, messo ko da un manrovescio della energica ragazza, che, dopo averlo colpito, aveva girato il sedere ed era scappata via piangendo e invocando il suo Bepi.
Quando si riprese, Benito corse via infuriato dallo studio e andò a casa. Distrusse tutto quello che si trovò alle mani, poi si sedette sul letto e cominciò a pensare. Non era mica finita lì!
Bellamossa! Pensò Benito dopo che, con un calcio in culo, aveva dato il via libera al vecchio Ceccotti, che, spaventato era salito di corsa sulla bicicletta e aveva cominciato a pedalare con energia per il sentiero.
-E ricordati che se apri bocca te la richiudo poi io e per sempre!- Aveva minacciato, anche se non ce n’era bisogno, Benito.
Ceccotti era un contadino che svolgeva varie mansioni alla villa della marchesa Monari-Serenini. Benito lo aveva atteso in fondo al sentiero che l’anziano percorreva tutte le sere, appena finito il suo lavoro alla villa, per tornarsene a casa.
Dopo l’episodio nello studio del medico Benito non aveva più saputo darsi pace. Quell’umiliazione non riusciva a buttarla giù. Sgorbio! Sgorbio, lo aveva chiamato quella culona. Voleva vendicarsi e aveva messo a punto un piano che giudicava perfetto. Per questo aveva dovuto avere pazienza per qualche giorno e fare finta di non sentire i risolini di scherno che gli aleggiavano alle spalle quando passava per strada. Ormai stava diventando un santo, pensava. Aveva parlato con un po’ di persone, facendo le domande giuste nel modo giusto. E quella era la sera giusta. Così aveva atteso il Ceccotti, lo aveva fermato e si era fatto spiegare bene dove si trovava la camera dell’Aurelia nella villa. Poi lo aveva lasciato andare dopo averlo minacciato. Per tutto il tempo Benito aveva tenuto il coltello in pugno, ben stretto e a pochi centimetri dagli occhi sbarrati del Ceccotti. Non avrebbe parlato, ne era sicuro.
Si sistemò all’esterno del muro di cinta, sopra un albero e tirò fuori dal tascapane, un pezzo di formaggio e delle olive. Mangiò con calma pregustando la vendetta, poi, quando fu certo che l’Aurelia fosse a letto, scese dall’albero e, con l’agilità di una scimmia, cominciò a scalare il muro di cinta. La camera dell’Aurelia si trovava a pianterreno, di fianco alle cucine. La terza da destra, gli aveva detto il Ceccotti. Attraversato il prato di corsa, Benito giunse davanti al suo obiettivo. La finestra era aperta.
-Bellamossa!- Ghignò soddisfatto.
L’Aurelia navigava beata in mezzo al mare. Il profumo di salsedine si mischiava a quello del suo Bepi, che la teneva stretta e le passava le dita sul seno. All’improvviso i profumi divennero una puzza nauseante; l’Aurelia si svegliò di soprassalto cercando di gridare, ma qualcosa le premeva la bocca. Mise a fuoco e vide la figura di Benito, a pochi centimetri dal suo volto. Ciò che le premeva la bocca era la sua mano che sapeva di formaggio stagionato.
-Se provi a urlare ti taglio la lingua- mormorò secco Benito facendole vedere il coltello che teneva nell’altra mano. Lei accennò un sì spaventato e il giovane le liberò la bocca. L’Aurelia, terrorizzata, alzò le ginocchia e se le strinse fra le braccia.
-E così sono uno sgorbio eh? Io che avrei fatto di tutto per te e invece mi sono dovuto sentire così umiliato. Ma ora ti faccio vedere io!-
Da un po’ di tempo la marchesa Monari-Serenini veniva colta da attacchi di fame notturni, tanto improvvisi quanto necessari di soddisfazione, per cui la nobildonna si alzava e scendeva in cucina, dove si beava in soddisfacenti spuntini, durante i quali, a volte, arrivava perfino a spazzar via tutto quanto c’era in dispensa. Quella notte non fu da meno, per cui la marchesa si stava dirigendo in cucina quando la sua attenzione fu catturata da dei rumori che provenivano dalla stanza dell’Aurelia. Erano risate! Risate forti, sguaiate. Che stava succedendo? Si chiese. Vinta dalla curiosità si diresse verso la camera della ragazza. Quando aprì la porta si trovò di fronte all’ultima scena che avrebbe potuto immaginare: in mezzo alla stanza c’era un uomo nudo dalla cintola in giù. A sedere sul letto, l’Aurelia, in preda a un attacco di risa incontrollabile.
Eh sì. Dopotutto l’Aurelia aveva avuto un solo uomo nella sua vita e, essendo una ragazza pudica, non aveva mai parlato di certe cose con altre donne. E quindi il suo unico termine di paragone era Bepi. Che, evidentemente, era stato generosamente ricompensato nelle sue parti intime da madre natura, tanto che (e pure questo l’Aurelia non poteva saperlo) al suo paese, là dalle parti dell’Ogliastra, era noto anche come “tubo da stufa”. Ed altrettanto evidentemente, Benito, dal canto suo, non rispettava la “regola della elle” per cui l’Aurelia, non appena si era trovata di fronte alla sua nudità, non era riuscita a trattenersi: il terrore aveva lasciato il posto a una irrefrenabile, lunga, roboante risata. Per la seconda volta Benito era stato umiliato, stavolta anche peggio della prima. Sorpreso dalla reazione della ragazza era indietreggiato di un paio di passi, mantenendo pantaloni e braghe abbassati e fu proprio in quella posizione che fu sorpreso dall’ingresso in scena della marchesa.
Ci fu qualche secondo di impasse, poi Benito si riprese. Muoveva rapidamente gli occhi dall’Aurelia che non riusciva a smettere di ridere e la marchesa, congelata con la mano sul pomello della porta. Valutò velocemente se usare mani o coltello, ma prima, pensò, sarebbe stato meglio tirarsi su i pantaloni. Si abbassò per afferrarli ma dovette rimanere in quella posizione, bloccato da una voce possente alle sue spalle.
-Fermo lì Benito!-
Merda, pensò Bellamossa. Aveva riconosciuto la voce.
Il maresciallo Calindri scavalcò la finestra, così come aveva fatto il finto sardo poco prima.
Il Ceccotti non ce l’aveva fatta. Aveva passato la serata a camminare avanti e indietro e a tavola non aveva toccato cibo. Eppure l’Anselma gli aveva preparato i tortellini. E il Ceccotti che non tocca i tortellini vuol dire una cosa sola: sta male! Allora l’Anselma aveva cominciato a incalzarlo e, in breve, il marito le aveva raccontato tutto. L’Anselma era schizzata in piedi, mestolo in mano e gli aveva ordinato di andare subito dai carabinieri. Il Ceccotti aveva ubbidito, era corso alla caserma e il maresciallo Calindri aveva capito in due secondi la situazione. Quindi si era precipitato alla villa della marchesa.
-Eppure ti avevo avvertito! Tirati su i pantaloni che mi fai pena- Benito ubbidì. Sentiva il fuoco divampargli fra le guance. Non solo era stato di nuovo umiliato dall’Aurelia, ma ci si erano messi anche la marchesa, prima, e il maresciallo, poi, a farlo precipitare nel burrone. Non sapeva che dire, non sapeva dove guardare. Fremeva di vergogna e di rabbia. Avrebbe solo voluto scomparire.
Quello che Benito non poteva immaginare (e nemmeno gli altri) era che fosse la marchesa a prendere in mano la situazione. La nobildonna riuscì a convincere il maresciallo a non portare il giovane in prigione. Ci avrebbe pensato lei a fargli rimettere la testa a posto. Il maresciallo, a sua volta, chiese e ottenne tutte le assicurazioni che quel mezzo delinquente non avrebbe avuto occasione di farle del male. L’assicurazione si chiamava Venanzio, l’uomo di fatica della marchesa: un marcantonio di quasi due metri e con due mani che sembravano badili. Ci avrebbe pensato lui a tenere d’occhio il piccoletto. Perché la marchesa ci teneva così tanto a quella specie di scimmia? Semplicemente ne era rimasta colpita quando lo aveva visto con le braghe calate. In pochi secondi aveva realizzato che un uomo così, più primate che umano, non ce l’ aveva mai avuto. Certo, se solo avesse avuto anche settanta anni, non lo avrebbe minimamente considerato, ma, ormai… poteva ben concedersi, alla sua età, un ultimo capriccio e sperimentare qualcosa di mai provato prima. Quando Benito si accorse del lampo di lussuria che brillava negli occhi della vecchia rischiò l’infarto ma, ne convenne, pur se rabbrividente, era ancora la migliore delle possibilità per lui.
Per qualche giorno nessuno vide in giro nè la marchesa nè Benito. Il giovane riuscì però a fuggire dalla villa dopo circa una settimana e riuscì a portare con sè anche un po’ di argenteria.
L’Aurelia se n’era già andata. Aveva deciso. Sarebbe andata in Sardegna alla ricerca del suo amore. Se fosse stato Bepi o un altro, sentiva che solo là avrebbe potuto trovarlo.
Solo molti anni dopo si ebbero notizie dei due. L’Aurelia non aveva trovato Bepi nè l’amore sardo, ma un industriale tedesco che aveva conosciuto quando faceva la cameriera in un ristorante sulla costa Smeralda. E aveva imparato la vita, l’Aurelia: stavolta, alle dimensioni che la natura ha donato agli uomini, aveva preferito le dimensioni che gli uomini donano alla natura, nella fattispecie rappresentate da un anello d’oro con un diamante grosso come un uovo. L’Aurelia sposò l’anziano tedesco e, memore degli insegnamenti della marchesa, ebbe una vita ricca di averi e di amanti.
E Benito? Benito si era aggregato a un circo. Dava sfoggio della sua forza eccezionale. Era noto come “Il piccolo uomo più forte del mondo”. Si era sposato con la donna barbuta, altra attrazione del circo. Non avevano figli, ma una mula che aveva chiamato Laurelia. E quanto si divertiva a riempirla di bastonate. Un giorno Benito fu trovato morto a pochi metri dalla sua mula. Tutti dissero che era stato un incidente ma, un nano che era stato il primo ad arrivare, giurava di aver sentito gli ultimi rantoli di Benito, prima di spirare. Gli sembrava che avesse detto qualcosa tipo: -La…laurelia… accidenti a te, mi hai fregato un’altra volta. Be…Bellamossa!
Dello stesso autore leggi anche:
Marco di Grazia
Nasce a Pescia (PT) nel 1969, esordisce nel fumetto nel 1997 come sceneggiatore della serie umoristica “Non calpestare le margherite” e della serie “Area 51” per i disegni di Marcello Mangiantini, con cui pubblica anche racconti brevi sulle riviste “Selen”, “Il giornale dei misteri”, “Gli amici del 2000”. Nel 2003 si occupa dei testi, sempre per i disegni di Mangiantini, della miniserie western “Il Diavolo Bianco”, anno in cui vince, inoltre, il concorso Giallowave e pubblica il racconto “Un facile caso”. Nel 2008 esce il primo romanzo, “Li chiamavano Bartali e Coppi”, seguito nel 2010 da “L’Ottavina di Dio” scritto a quattro mani con Francesco Villari, con cui pubblica, nel 2016 un altro romanzo: “Democracia Futebol Clube”. Nel 2016 è finalista del Lucca Project Contest con la graphic novel “Cinque minuti due volte al giorno; nel 2017 scrive la piece “Vixerunt”, una storia narrata, disegnata e recitata, e il racconto\fiaba “L’uomo che custodiva la musica” con le illustrazioni di Cristiano Soldatich. Fa parte dello “Studio Sciupòn” insieme ai disegnatori Giovanni Ballati, Riccardo Innocenti e Cristiano Soldatich e allo sceneggiatore Iacopo Innocenti; e del collettivo di artisti “Abrazo Futbolero”, attivo in tutta Italia con mostre, manifestazioni, presentazioni e diverse altre attività.
 Zoomma Dove scoprire nuovi interessi
Zoomma Dove scoprire nuovi interessi