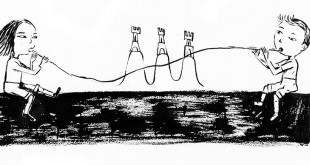Una questione di cuore
di Barbara Carraresi
Settembre. Con qualche centimetro in meno di altezza si campa lo stesso. Fin da piccola ho dovuto fare i conti con una statura… ridotta, diciamo così. Ben più difficile invece è sopravvivere con un cuore che batte a un ritmo diverso dal normale. La mamma urlava dal terrazzo che non dovevo correre coi miei amici. Allora non capivo perché. Non sapevo che uno sforzo eccessivo avrebbe potuto arrestare la mia corsa per sempre. «Signora non si preoccupi», rassicurava il cardiologo. «Sua figlia ha una gran fortuna. Non è cresciuta molto, quindi il suo cuore si stanca meno del dovuto. Credo che l’intervento sia scongiurato fino all’età della pensione». I medici non dovrebbero mai esprimere opinioni personali né, tantomeno, illudere i pazienti. Io avevo sentito tutto e tirai un sospiro di sollievo. Comunque continuavo a star seduta sul muricciolo con le gambe penzolanti e la testa chissà dove mentre gli altri bambini giocavano a rimpiattino. Una noia mortale, però sempre meglio che finire sotto i ferri, no? Ero convinta che con le dovute precauzioni avrei preservato la mia salute integra fino alla vecchiaia. Errore madornale.
Ottobre. È andata a finire che pur avendo rinunciato per tutta l’estate ai giochi all’aria aperta, l’autunno successivo mi sono ritrovata di punto in bianco su lenzuola candide col marchio dell’azienda ospedaliera Careggi. Passavo le ore a guardare milioni di foglie rosse e gialle che cadevano all’impazzata nel giardino, nell’attesa di essere operata. Fu una degenza lunga per colpa di mille accertamenti e preparativi. «Un peggioramento improvviso, mi dispiace signora». Per il medico il mio caso era solo un pronostico sbagliato e un conseguente cambiamento di programma in sala operatoria. Per me un colpo fra capo e collo, un evento a cui non ero affatto preparata. Gli zig zag di inchiostro dell’elettrocardiogramma ballavano sullo schermo come schegge impazzite, in una danza scomposta, in un caos incontrollabile. Anche il mio petto era in subbuglio. Non sentivo un battito uguale all’altro.
La cassa toracica era diventata il tendone di un circo con un cuore acrobata che faceva capitomboli. Non so se per la paura o per l’affaticamento eccessivo. Fatto sta che era arrivato il momento tanto temuto: quello dell’intervento. «Ha il sessanta per cento di probabilità di superare l’operazione», sentii affacciandomi di nascosto in punta di piedi alla vetrage della sala medici, leggermente socchiusa da una parte. Da quello spiraglio passavano aria intrisa di odore di alcol e parole maledette. Avrebbero dovuto tenerlo ben chiuso. La verità per una piccola paziente come me doveva essere inaccessibile, impenetrabile e invece mi resi conto dell’enorme rischio che stavo correndo in modo schietto e improvviso, senza tanti salamelecchi. Tornai a letto a testa bassa e mi tormentai tutto il giorno domandandomi per quale accidenti di motivo avevo voluto ascoltare. Nella vita è cento volte meglio non sapere, ripetevo a me stessa scuotendo la testa. La sera prima dell’operazione salutai i miei genitori in un commiato disperato, come fosse un addio. Non avevo tutti i torti. Avevo appena scoperto che c’era il quaranta per cento di probabilità che lo fosse davvero. Temevo di non vederli più. «Andrà tutto bene» disse la mamma cercando di nascondere la gran pena che le devastava il cuore.
«Non gufare» l’azzittii io. «L’ultima volta che il dottore mi ha visitato non ha azzeccato neanche un po’ le previsioni» Il babbo si intromise per cercare di smorzare la tensione. «Come poteva sapere? La medicina non è una scienza esatta. Non ci sono certezze». «Appunto!» Esclamai allontanando tutti e due con un rapido gesto del braccio e trattenendo un’esplosione di lacrime. Intanto le foglie continuavano a formare nuovi strati sul soffice tappeto autunnale nel giardino dell’ospedale.
Novembre. Per un tempo indeterminato, non quantificabile soltanto con lo scandire delle lancette dell’orologio, rimasi in sospeso fra la vita e la morte, fra un passato certo e un futuro solo possibile.
Il buio, il silenzio, il vuoto, il nulla. In una parola anestesia. Subito dopo l’operazione trascorsi due giorni in terapia intensiva ma potevano essere mesi o anni per quanto ne sapevo. Poi un tenue raggio di sole entrato dalla finestra mi fece svegliare di scatto dandomi la forza per affrontare tutto il resto. Ero viva e il quel preciso istante mi sembrava già una grande conquista. All’inizio si susseguirono giorni difficili. Una ferita enorme divideva il mio sterno a metà e il dolore nel guardarmi non era solo fisico. Ma il cuore non faceva più capricci. Il cavallo selvaggio e recalcitrante che mi portavo dentro da dodici anni si era trasformato in un docile ed energico roano al trotto. Il suono un po’ metallico ricordava il ticchettio dell’antica sveglia con la carica a molla che la nonna teneva sul cassettone. Non era vellutato e morbido come lo ricordavo. Pazienza, mi sarei abituata presto al nuovo ospite. A quella valvola meccanica dovevo la vita, in fondo. Perciò era la benvenuta anche se un po’ antipatica e invadente. Imparammo a sopportarci a vicenda. Io cominciai a tollerare il suono del titanio e lei a sostenermi nell’affrontare i primi passi e gli scalini.
Dicembre. Al posto delle foglie cadevano dal cielo coriandoli di neve e il vetro si annebbiava col respiro del mio naso, sempre incollato alla finestra. Vedevo passare le stagioni, mentre il tempo dell’attesa sembrava non passare mai. Ma arrivò anche il giorno delle dimissioni, dopo un lungo periodo di riabilitazione. Quando appoggiai le suole delle Nike in giardino, dopo mesi in pantofole, parlai alla valvola come a una compagna di avventure.
«Forza» sussurrai con un filo di fiato affinché nessuno mi sentisse «finalmente possiamo correre». Mi sentivo una gabbianella che deve imparare a volare. Non scorderò mai la prima planata ad ali spiegate dopo tanti tentativi andati a vuoto. Allargavo le braccia fingendomi un aereo fra le nuvole e ridevo, fremente di tornare a casa e sfidare i miei amici ai cento metri. Non avevo mai sentito l’aria pungente dell’inverno sfiorarmi il volto, né la contrazione dei muscoli, falcata dopo falcata. Quella leggerezza era esistita solo nei miei sogni. Più correvo e più la resistenza del corpo diminuiva e i polmoni si gonfiavano di un’aria frizzante e ossigenata.
I tigli immobili osservavano in silenzio la mia corsa verso una vita nuova. Mi sentivo finalmente felice. Mi ero liberata di un peso troppo grande da sostenere a quell’età. Gli amici di sempre mi accolsero con un enorme orsacchiotto di peluche che posai subito per condividere con loro la prima pedalata della mia seconda infanzia. Alla visita di controllo il cardiologo disse che a quel punto le aspettative di vita erano uguali a quelle di qualunque essere umano. Vista la sua abilità nel prevedere il futuro non sapevo se fosse vero, ma decisi di crederci.
Un anno dopo. La ferita era rimarginata bene, almeno in superficie. Fra le pieghe dei tessuti e della mente invece era destinata a rimanere impressa come un marchio a fuoco, per tutta la vita. Alzai lo sguardo e incrociai gli occhi patinati di Antonio, azzurri come un mare caraibico, che mi guardarono in modo diverso. «Ti va un gelato?» Chiese balbettando timidamente. Nel petto avvertii un sussulto. Non un rumore metallico, più una sorda rullata di tamburi, preludio di una grandiosa melodia. Il cuore, dopo tanta sofferenza, mi stava regalando il primo palpito d’amore.
 Zoomma Dove scoprire nuovi interessi
Zoomma Dove scoprire nuovi interessi