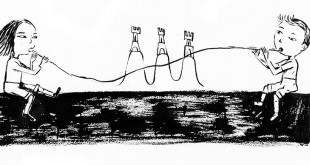Mi assale la malinconia, ma forse sarà la pioggia di questa giornata d’ottobre. Se alzo gli occhi verso la Città, mi pare di vedere ancora gli aerei sfilare e le bombe cadere attorno, squassando l’aria. Era di giugno, del ’44. Avevo otto anni e stavo giocando per strada coi compagni più grandi, inseguendo la caratella che cigolava dalla piazzetta verso Ca’ Berlone, sollevando nugoli di polvere. Arrivarono. Ci fermammo tutti a osservarli, dentro e fuori le nuvole, sprazzi argentei come ogni giorno abituati a vederli passare.
Poi il rumore si fece più forte e cambiò d’intensità, pareva il fischio di Bumbòun, quando chiamava gli amici nei campi. Il monte divampò per le esplosioni,
che si ripercossero in echi spaventosi lungo tutto l’Appennino. Il monte bruciava, come i miei occhi, feriti da quel tradimento inatteso.
I vecchi iniziarono a urlare, portandoci via dalla strada, verso i campi, in chiesa, le donne abbandonarono i fornelli e il pranzo ormai pronto. Mio padre mi prese per un braccio e iniziò a correre verso la collina di fronte, masticando parole che ho compreso solo dopo cresciuto.
Durante il cammino, passò un secondo stormo a bombardare la Città, un terzo fece tremare il monte dalla parte del mare. Ansimando e piangendo, tante persone cercarono scampo nei boschi. Non c’erano rifugi, al massimo una vecchia cantina. Noi eravamo neutrali, perché ci facevano questo? Gli aerei tornarono per un ultimo assalto, scaricando altre bombe. Ancora oggi mi chiedo se sbagliarono la mira o se lo fecero apposta, di bombardare dei miseri passanti. Bumbòun non ne aveva mai fatti, di fischi così forti, ma erano delle bombe che ci cadevano sopra la testa, mentre il rombo degli aerei scivolava lontano.
Fummo sbalzati a metri di distanza, chi a terra, altri fra i rovi, in una pioggia di schegge e sassi. Quando il bombardamento cessò, contammo i morti, cercandoli sul sentiero che saliva a Montalbo. Io venni portato via, per non vedere quel macello, ma attorno c’erano 26 scarpe rotte e corpi smembrati, che me li sono sognati per anni. Le grida dei parenti sovrastavano il fumo e la polvere degli scoppi, aumentando a dismisura il nostro dolore. Trovammo Irma fra l’erba del campo, schizzata del sangue che imparammo in seguito essere dei suoi. Non aveva niente, niente che giustificasse i suoi occhi sbarrati e il suo mutismo. Attorno era rabbia e sgomento, ma mio padre comprese che nessuno dei due si sarebbe preso cura della piccola orfana. Fece un cenno con la testa a mia madre, poi s’avviò verso il paese. Portammo Irma con noi. Nei giorni che seguirono la tenemmo in casa, lavata e pettinata, ma lei non parlava e pareva non ci ascoltasse quando le chiedevamo delle cose. Siccome nemmeno piangeva, fu chiamato il parroco, Don Juséf, che la guardò per qualche minuto, carezzandola e parlandole dolcemente. Irma se ne stava zitta, gli occhi sbarrati a fissare il fuoco.
Nemmeno il dottore ne cavò nulla, e concluse che le esplosioni l’avevano traumatizzata. Occorreva solo darle tempo e lasciarla tranquilla. Non tornò più a vederla. Irma trascorreva le giornate da sola, portandosi dietro un gattino ovunque andasse. Lo teneva addosso, in grembo quand’era seduta, oppure si rotolava con lui nella polvere. Ma senza mai dire una parola. Spesso ho cercato di stare con lei, di parlarle, giocarci assieme. Lei prendeva il gatto e andava da un’altra parte. Allora chiesi a mio padre cos’avesse, ma non me lo seppe dire. Fu mio nonno che mi raccontò di cosa accadeva durante la guerra, quella del 15, dov’era stato in trincea. «Ti scoppia la testa, Francesco, quando la bomba esplode troppo vicino. Diventi sordo, oppure impazzisci. Ho perso tanti amici, così. Si sono buttati addosso al nemico, oppure sono spariti nel nulla, disintegrati. Sta con lei, forse le passerà…». Me lo disse in dialetto, ma sono passati troppi anni e non ricordo più bene. Scoprii da solo che Irma non era sorda:bastava m’avvicinassi di soppiatto che lei mi sentiva e scappava via.
A volte la spiavo da lontano, da dietro il pagliaio o il pozzo. E allora la sentivo parlare al gatto, cantare per lui. Me ne innamorai subito. Anno dopo anno crescevamo distanti, io col lavoro nei campi, lei coi suoi gatti, sempre più numerosi. Il maestro di scuola mi disse che le faceva bene occuparsi di loro: oltre a trascorre il tempo con meno apatia, l’aiutava a trovare uno scopo nella vita. Col tempo i paesani l’avevano soprannominata Irma di gat, Irma dei gatti, per non confonderla con Irma… un’altra cosa. Da sei anni arrivò a dieci, poi 27 a sedici. In lei cambiò solo l’aspetto fisico e la compagnia dei gatti, rinnovata anno dopo anno. A modo nostro, diventammo amici.
Io avevo il permesso di sedere accanto a lei e di giocare coi suoi gatti. Me ne allungava uno e potevo tenerlo per qualche minuto, fino a che non l’assaliva la voglia di riprenderselo. Leggevo nei suoi occhi chiari quel sentimento, allora lo prendevo e glielo mettevo fra le mani. A volte sorrideva. Io le parlavo, le dicevo quanto l’amassi, che l’avrei amata anche così, se solo mi avesse chiamato per nome, anche una sola volta. Lei si lasciava carezzare i capelli color dell’oro e portare a spasso tenendoci per mano. Ma capii che non avrei mai potuto sposare una donna con dentro una bambina di sei anni. Soffrii moltissimo, quando l’abbandonai, ma a vent’anni avevo perso mio padre e la possibilità di sostenere la mia famiglia.
Emigrai, lasciando Irma, i suoi gatti e un amore impossibile.
Chiusi gli occhi per non vedere il monte sparire dietro la corriera e riaprii il mio cuore solo varcato il confine d’oltralpe, a Parigi, dov’ero destinato. Lo riaprii vent’anni dopo. Durante tutto quel tempo, scrissi ogni mese a mia madre, inviando i soldi per la famiglia e chiedendo di Irma, di come stava e se le mancavo. Le risposte erano sempre le stesse. Aumentavano gli anni, aumentavano i gatti, ma lei era rimasta chiusa nel suo guscio di sogno e viveva bene così. Le spedii una foto,
anni dopo, seduto nella mia auto sportiva, con una sigaretta accesa in bocca. Le mandai anche un vestito e un cappellino. Quando ricevetti la risposta, risi fino alle lacrime, poi piansi fino alle risate. Per tutta la notte. Scrivevano che Irma aveva mostrato la foto a ogni gatto che custodiva, più volte, costringendoli quasi a sbatterci il muso. Poi aveva messo i gatti nati da poco dentro il cappellino e stracciato il vestito, facendone un nastro per i gatti maschi e una mantella per le femmine.
A modo suo, li aveva sposati. A modo suo, mi aveva sposato.
Aspettai altri dieci anni, prima di prendere moglie, ormai a quarant’anni. Cercai, fino a trovarla, una stabilità interiore, fino a dimenticarmi di Irma, dei suoi gatti e dell’aria bollente del bombardamento. Non tornai più a casa, a guardare il monte e i palazzi che crescevano come funghi nei boschi, mi bastavano i racconti delle
mie sorelle, subentrate a mia madre nella ormai rara corrispondenza.
Crebbi figli miei, di due mogli diverse.
C’est la vie…
Immaginavo il paese che mi raccontavano dentro le lettere, le vecchie case ricostruite, la chiesa che adesso scandiva le ore col nuovo orologio, come nelle vecchie pellicole di Fernandel. Pensavo ai vecchi, che non c’erano più, all’Angiulla, l’Ernesta, Mingòun, Faféin, Gudanzòun e chissà quanti altri, che la mia memoria di vecchio ha seppellito fra i ricordi dimenticati…
Piove più forte, adesso. Ci ripariamo sotto la tettoia del cimitero di Montalbo. Mentre l’arciprete recita l’orazione funebre, mi appoggio al muro e accendo una Gauloises. Quando mia sorella mi ha chiamato, avvisando che Irma era morta, mi sono sentito male. Sono tornato di corsa a casa, qui, per il funerale, per darle l’ultimo saluto. Ora mi tocca seppellirla senza nemmeno averla rivista. Mi consola appena la foto del ricordino, che la ritrae qualche anno fa, sorridente.
M’avesse fatto appena un cenno, da giovane, sarei rimasto con lei e i suoi gatti, a tenerle la mano fino alla fine, parlando per tutti e due, vivendo per tutti e due. Ora mi rimangono solo i suoi gatti, mi fermerò ad accudirli nel suo ricordo…
Mi raccontarono che l’avevano trovata in un caldo tramonto d’ottobre, adagiata sul sentiero di trifoglio, come addormentata.
Attorno giocava uno stuolo di gatti, altri s’erano accoccolati accanto a lei, come d’abitudine. Il più piccolino dormiva appoggiato alla sua bocca, pareva che lei lo baciasse. E lei forse lo stava davvero baciando, quando se n’è andata.
Tintinna una campanella, ci segniamo con la croce. Persone affrante sotto gli ombrelli. Pochi minuti ancora, poi solo una foto ricorderà chi era, cos’era per noi.
Irma dei gatti…
Walter Serra
 Zoomma Dove scoprire nuovi interessi
Zoomma Dove scoprire nuovi interessi