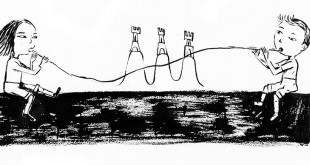Uscì dal retro della cucina. Una donna piccola dai capelli rosso henné raccolti a crocchia sul capo. Indossava un semplice abito nero aderente, scollato senza voler provocare, le ginocchia appena scoperte. La sua espressione era serena. Eppure il viso era già segnato dalla stanchezza in quel caldo primo pomeriggio di fine luglio privo di vento. Era lì per lavorare: cuoca o qualcosa di simile, comunque un ruolo a metà tra il maître di sala e la sguattera. Mi fu presentata come una carissima amica andata lì per aiutare la baracca a decollare, e io divenni a mia volta un bravo cuoco, provetto nella preparazione del cuscus. La sua espressione stupita, incredula, ironica e strafottente allo stesso tempo, mi fece esplodere in una risata che veniva da dentro l’anima e mi sollevava lo spirito dal buio nel quale si era nascosto negli ultimi mesi.
«Non è vero», risposi guardandola dritta in viso, «però magari una sera facciamo qualcosa insieme».
Il suo: «Vedremo. Beh, ciao, ora vado. Ho da fare», misero fine a una conversazione impacciata e timida, durante la quale già mi ero reso conto di quanto quella donna mi piacesse. Sparì dietro una tenda di perle di plastica, ma sentivo di averla trovata.
Era la prima estate che avrei trascorso senza il pensiero di una compagna lontana alla quale dedicare il primo saluto del mattino e l’ultimo pensiero della notte. Ero e mi sentivo libero, in pace con me stesso e forte. Ero sereno e felice di essere lì in quel posto dove ormai sentivo di avere radicato una parte del mio essere: un uomo complesso e spesso contorto, che nella semplice e spartana vita di mare riusciva recuperare una espressività immediata e lineare, senza gli orpelli e le sovrastrutture che la vita di città impone.
Era con il mare che mi immedesimavo. Ed era nel mare, nel suo continuo e immutabile divenire, che trovavo la gioia di essere semplicemente me stesso, tuffandomi tra le onde, immergendomi nelle sue profondità, sedendo sulla riva per ore, immobile, perso nel movimento di ogni singola increspatura, nel suo interminabile, infinito, eterno, ripetitivo, eppur sempre nuovo e diverso, divenire.
La rividi qualche sera dopo, e il caso volle che il solo posto libero della lunga tavolata fosse di fronte a lei. Ero contento ed emozionato e mi sentivo impacciato, vestito com’ero di un semplice pareo, a stare di fronte a lei che ai miei occhi pareva appena uscita da una sfilata di moda. Non ricordo neanche più cosa le raccontai di me, né se anche lei mi disse qualcosa di sé, della sua vita, del perché fosse capitata in quel posto per fare un lavoro che non le piaceva.
Quelle briciole di ore divennero un rifugio senza tempo, né spazio, né suoni. C’era lei e null’altro. Le offrii un caffè e camminandole accanto mi accorsi di quanto fossero lunghi e tanti i suoi capelli. Li toccai con delicatezza facendoli scivolare tra le dita aperte della mano, ruvida per le tante ore in mare e aperta a cogliere sensazioni nuove.
«Sono bellissimi i tuoi capelli», le dissi. Poi, con semplicità, le strinsi la mano e camminammo così per pochi metri, senza parlare né muovere le dita, eppure vicini. Fino a che gli altri non ci separarono e lei andò via nella notte lasciando un’ombra di luce nel mio cuore. In quel momento mi resi conto che avrei potuto di nuovo perdere la mia libertà, ma non me ne preoccupai. Speravo solo di rivederla.
Era un vita caotica e nevrotica quella che si faceva allora. Si condividevano le fatiche del preparare le uscite in mare, si parlava con i subacquei e con gli amici di ciò che si era vissuto nel breve tempo dell’immersione. Si condividevano le sensazioni, le paure, gli scherzi fatti durante i trasferimenti in barca. Ci si conosceva.
Quel modo di vivere faceva sentire liberi, senza limiti di spazio né vincoli che potessero impedire ai sentimenti di crescere e di radicarsi nell’anima. Così la cercai ancora, approdando con la mia barca sulla spiaggia del suo mare, di pomeriggio, quando dopo il lavoro recuperava forze per la sera, stesa su un lettino e apparentemente assopita. I capelli raccolti sulla nuca le scoprivano il collo e le spalle, la pelle scurita dal sole rifletteva piccole gocce di acqua. Era bella e me ne saziavo lo sguardo mentre, steso sulla sabbia, cercavo parole che non fossero banali per chiederle di vederci da soli.
Venne dopo il lavoro. Sembrava triste e indifesa mentre parlando ci avviavamo verso la spiaggia per trovare un luogo dove il buio potesse nascondere le nostre emozioni. Le rubai un bacio. Mi accolse e mi respinse mentre per un solo breve attimo posava la guancia sul mio petto dicendomi: «Non posso, non ora, scusami». Parlammo ancora e le raccontai di me, del mio dolore passato e della gioia del presente, liberando tutti i ricordi e i sogni che avevo tenuto chiusi dentro di me in quegli ultimi mesi di solitudine.
«Non sono come gli altri», le dissi, «mi scoprirai vivendomi e per te sarà impossibile liberarti di me». Non erano una minaccia quelle parole, né una dichiarazione di presunzione, ma allora sentivo che sarebbe stato vero.
Il suo mare divenne un rifugio dalle tempeste e una tappa fissa al ritorno dalle immersioni. Un saluto, una conchiglia lasciata nella mano tesa, un sorriso, un semplice: «È per te».
Il ritorno a casa, con l’immagine del suo viso e della sua espressione seria e sorpresa negli occhi, suggellò quel giorno la semplice gioia di un fugace incontro.
«La conchiglia è bellissima», mi disse più tardi, «chissà quante cose ha da raccontare. È bello vederti arrivare dal mare. Yemaya ti dà un’aria serena e di forza. A volte, quando arrivi, sembra di essere avviluppati da una folata di vento».
Mi aprì il suo mondo con quelle poche parole. Un mondo fatto di fede e di miti, di quotidiano e di magia, di riti e di ricchezza spirituale. Un mondo per me nuovo e del tutto sconosciuto.
«Yemaya, oricha del mare, è la madre di tutte le madri», mi spiegò. «Lei non ha corona, veste di bianco e azzurro. Le sue acque d’improvviso possono agitarsi a tal punto da diventare pericolose. Yemaya è amica di Ochùn oricha dei fiumi, che è dolce come le sue acque. Lei è l’oricha dell’amore … e ora ti sta baciando», concluse stringendosi a me.
Il suo amore era dolce e i suoi occhi neri brillavano di felicità nel buio di quelle ore rubate alla notte. Fare l’amore era un gioco nel quale ci scoprivamo, ridendo di noi stessi e delle nostre timidezze, e il tempo si dilatava fino a farci dimenticare finanche di esistere. Sfiorare la sua pelle mi ridava il sorriso e il gusto della vita; la sua presenza mi fece provare di nuovo l’azzardo del rischio, la voglia di costruire, il piacere dell’amore, dell’essere dolce, del vivere una realtà tanto forte e coinvolgente, con la serenità del sapere che c’era tempo per noi nel nostro futuro.
Partii per alcuni giorni e mi accorsi di quanto fosse cambiata la mia capacità di percezione del mondo esterno, di quanto non avessi timore di mostrare la mia fragilità o i miei stati d’animo. Mi sentivo come un naufrago che, approdato su un’isola sconosciuta, avesse scoperto di trovarsi su una spiaggia di sabbia corallina, bianca e fine, definita come una falce di luna tra il blu del mare e il verde della vegetazione. La mia stessa ombra quasi non esisteva per quanto il sole era verticale. La luce era violenta e nell’aria immota c’era felicità. Solo il mare che lambiva la riva parlava, e nella sua lingua misteriosa mi diceva: «Sei giunto, infine. Questa è la tua casa, e questa sabbia che calpesti senza quasi lasciare tracce è la soglia del tuo futuro».
Camminavo sorridendo attraverso la spiaggia lasciando il suo splendore per un’ombra verde di foglie e di mistero. Il profumo intenso dei fiori mi accolse. Il terreno nero e soffice non aveva sentieri, ma sosteneva le mie orme. Ogni passo mi sospingeva verso un mondo ignoto nel quale il silenzio colpiva i miei sensi come fosse un suono delicato vibrante nell’aria. Attorno, ovunque, una presenza, un sogno forse, una figura di dea che mi veniva incontro, un rosso fiore di ibisco tra i capelli, il sorriso aperto, gli occhi colmi di luce. Le portai un fiore rosso.
«Perché il fiore rosso?», mi chiese. «Il colore di Ochùn è il giallo, come l’oro suo simbolo. I suoi attributi sono inoltre ventagli e campanelli. La sua risata è aperta e squillante, ma attenzione a quando ride troppo … arrivano i guai. Lei fa magie per i giovani innamorati e tutti si innamorano di lei. Lei è vita», concluse con un’espressione sbarazzina.
Quella notte scoprii la sua bellezza, la sua forza e la sua fragilità.
«Sei dolce e appassionata nell’amore. Sai amare e dare te stessa con sicurezza. A volte piangi quando un fantasma ti sfiora. Sei una donna rara e non voglio perderti», le confidai sussurrando, il volto immerso nei lunghi capelli sciolti sulle spalle nude.
Sparì nella notte. Un messaggio proveniente da un passato felice e al contempo doloroso le aveva riaperto una ferita ancora non sanata; una violenza che la perseguitava di continuo esaltando i ricordi e che si sarebbe sopita solo anni dopo con un incontro nel quale ebbe, forse, modo di dire il non detto e di essere finalmente se stessa senza vincoli né paure.
Forse era giusto restare un po’ da soli per poterci ritrovare. Ognuno ha i propri fantasmi che tornano prepotentemente, più o meno voluti, cercati o subiti, e spesso sono il mezzo per liberarci dai fardelli che ci tengono legati al nostro passato. Il ripiegarsi nel dolore del ricordo, a volte può avere un valore catartico che porta a trovare nuova forza per risorgere e riprendere il faticoso cammino della costruzione di noi stessi.
Piangere dopo l’amore per un rimpianto rimasto annidato nel cuore è come liberarsi dal ricordo e accettarlo, infine, come una parte del nostro passato, irripetibile, irrinunciabile ma ineluttabilmente superato dalla realtà. Quella stessa realtà che ci predispone a vivere un nuovo amore con la certezza che sia vero, unico e non filtrato dai nostri ricordi.
«Eppure», le dissi allora, «sappi che io non vorrei mai una donna senza ricordi, perché chi non ha passato o non lo accetta, non può essere consapevole del suo presente».
«Perché non vedi che sono lì», mi rispose con un’espressione di soffusa tristezza, «ma con te non ho più paura di niente e potrei affrontare qualsiasi cosa. Mi piace il tuo sorriso, ma quando inizi a parlare in modo un po’ più serio, è allora che mi piaci di più», concluse dischiudendosi al sorriso.
Eravamo felici in quei giorni. Ci mancavamo, eppure eravamo in grado di vivere le nostre vite senza interferenze né rimpianti. Avevamo un progetto e a volte ne parlavamo, quasi volessimo dimenticare che il nostro presente era più complesso di quanto fossimo in grado di accettare.
«L’idea di vivere con te mi rapisce oltre il tempo», mi disse, e io ne fui felice.
Parlammo di questo nostro nuovo sentire e, dopo, il nostro amore fu più profondo, più intenso, consapevole e pieno. Era la consapevolezza che sarebbe potuto esistere un futuro per noi, e le sue parole d’amore ne furono la conferma
«C’è una differenza tra noi in questo momento della nostra vita», le dissi, «io posso essere libero di cambiare la mia all’istante, mentre tu sei costretta a scegliere tra sicurezza e azzardo. Solo il tuo cuore può farlo. Io non posso aiutarti in questo. Posso solo cercare di farti capire che non c’è baratro dinanzi a me, ma solo una strada con curve e salite, dura da percorrere, eppure con una fine splendida, se riusciremo a percorrerla insieme».
«Avrò i colori di Yemaya questa sera», rispose. «Li porterò in suo onore perché ci ha fatto incontrare. Con le sue onde sta portando via tutti i fantasmi, mi fa sentire bella standoti vicino, mi fa sentire potente con il tuo sguardo. Portami via da questo mondo, voglio stare con te».
Mi aiutasti a fugare i miei fantasmi con quelle parole e trovai il coraggio di chiederti un qualcosa che credevo di avere rimosso dai miei desideri. Rispondesti con un sussurro in punta di anima, con emozione e gioia e con il timore che generava la gravità della scelta. Fu una promessa per entrambi, ma non ci vincolò a non darci dolore e sofferenze come sarebbe poi accaduto. Eppure, in quei pochi giorni, in lei era cresciuto un amore incredibile e determinato.
«So che mi sconvolgerà dal profondo», mi confessò con una insolita dolcezza nella voce, «so che sta iniziando un nuovo tipo di vita. Sento la felicità come un sogno che si sta realizzando, con i suoi tempi e modi, ma positivo».
Mi strinse a sé e soffocò con un bacio la mia risposta. Poi mi prese tra le sue mani e mi condusse nei sentieri del suo piacere. Mi accolse, mi avvolse e mi scosse fino a fondersi con la mia linfa, unita a me da mille fili invisibili e tenaci. Urlammo i nostri nomi al vento, allo stormire delle foglie, ai riverberi accecanti del sole tra i rami, senza più tempo né spazio, sospesi nei nostri respiri, persi nella consapevolezza di essere uniti.
«Preparati perché ti starò attaccata sempre», mi minacciò sorridendo della mia reazione stupita. «Dal momento in cui arriverò da te sarò tua, come vuole il destino», disse, prima di esplodere in una risata che le erompeva dagli occhi. Fui felice di quelle sue parole
Partì per tornare al suo mondo, per affrontare la sua vita e io mi sentii improvvisamente vuoto, ma non ero più solo. Lei esisteva ed era, come me, pronta a entrare nell’avventura di una vita diversa e finalmente sua.
La rividi anni dopo. Era una donna ormai, completa e sicura di sé.
Diceva di essere felice, ma guardando l’espressione dei suoi occhi, mentre parlavamo di noi, ebbi l’impressione che le mancasse ancora qualcosa per sentirsi totalmente realizzata.
L’amai ancora di più.
Ma tutto questo, ormai, è passato.
 Zoomma Dove scoprire nuovi interessi
Zoomma Dove scoprire nuovi interessi