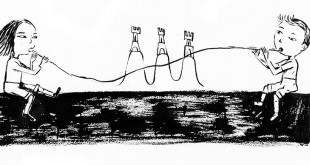Il mare di Ostia
di Costantino Meucci
Il mare di Ostia era calmo e stranamente pulito quel giorno, ma questo accadeva tanto tempo fa, nel 1954. Già, il Millenovecento cinquantaquattro, un anno cruciale per molti aspetti nell’Italia del dopo guerra e della imminente ripresa economica ‘… 1954: si risolve la questione di Trieste: la città all’Italia, l’Istria alla Jugoslavia. … 1954: in Italia, in attesa della morte di De Gasperi, si scatena la guerra di successione nella DC; il dinamico Amintore Fanfani, accreditato come “sinistra” democristiana, utilizza abilmente un episodio di cronaca nera, il “caso Montesi”, per far fuori il suo più pericoloso concorrente interno, Attilio Piccioni. 1954: da Napoli Salvatore Lucania, alias “Lucky” Luciano, arrivato da New York, organizza le tradizionali attività illegali della malavita organizzata, tra cui il traffico di droga. 1954: in Italia arriva la televisione.’’ (da L’Unità, venerdì 8 marzo 2002: 1954 – Le profezie di Wu Ming. Tra gli Usa della guerra fredda e l’Italia di Fanfani: un altro romanzo storico del collettivo bolognese, di Antonio Caronia).
Fatti di cronaca dei quali ancora oggi, nonostante siano passati più di 50 anni, si risentono i contraccolpi, sordi, sotterranei e sottaciuti, ma persistenti e forti, come il riflusso di un’onda di marea che scava il fondo della riva lasciando scoperti oggetti sepolti da secoli. Un anno nel quale si scatena la fantasia degli scopritori di nuovi mondi e di civiltà extragalattiche, un anno nel quale ci si accorge che gli UFO sono tra noi: ‘1954: Com’è noto, quest’anno fu segnato da una delle maggiori ondate di avvistamenti UFO della storia italiana. Al momento attuale, quasi il 50% dei pezzi archiviati dall’Operazione Origini riguarda il ’54. Dopo notizie isolate nei mesi da gennaio ad aprile, da maggio a luglio si ha una discreta intensificazione delle notizie dall’estero e la comparsa di qualche isolato avvistamento italiano. Il mese di agosto vede una crescita significativa, soprattutto verso la fine, sia dei fatti stranieri che di quelli italiani.’, (da: Introduzione all’operazione origini, di Giuseppe Stilo, Pinerolo (Torino)). E questa sarebbe stata una notizia che avrebbe acceso l’attenzione e attivato la penna di Peter Kolosimo, sui cui libri mi sarei più tardi divertito a fare congetture e ipotesi fantasiose, quanto suggestive.
Anche per me quell’anno rappresentava qualcosa di diverso e di nuovo. Avevo, infatti, imparato a nuotare. In un giorno di mare altrettanto calmo mi ero incamminato verso il largo: ero curioso di scoprire cosa potesse esserci dove l’acqua era più alta, desideroso di superare quel limite invalicabile impostomi dai miei genitori i quali, con una costanza e una ripetitività quasi asfissianti, mi rammentavano, ogni volta che entravo in acqua, di non allontanarmi e di “non andare dove non tocchi” oppure, dopo la merenda di “non bagnarti lo stomaco, ché hai appena mangiato”. Quale migliore invito a bagnarsi il costume e poi la pancia e quindi lo stomaco, fino a cadere, del tutto accidentalmente, in acqua rimanendo fradici e gocciolanti in attesa del fatidico urlo “vieni qui ad asciugarti, subito!”. Ebbene, spinto dalla curiosità e nel silenzio più totale, mi ero diretto verso il mare aperto, facendo attenzione a poggiare bene la pianta dei piedi sulla sabbia appena ondulata del fondo, la testa bene eretta e il mento alto, poiché avevo paura di non toccare e di non poter respirare.
Avevo l’acqua appena sotto il mento e il passo successivo mi aveva portato a non sentire più nulla sotto di me; estendevo le dita dei piedi, ma la sabbia compatta del fondo era scomparsa, sparita: non toccavo. Eppure galleggiavo. I polmoni serrati pieni di aria facevano da cassa di galleggiamento, ma questo lo avrei capito anni dopo andando a pescare in apnea; per ora ricordo solo che la paura di non riuscire a tornare indietro mi aveva fatto trattenere il respiro. Così, continuando a sgambettare come se stessi camminando, restavo a galla. La testa era sempre fuori dell’acqua, la bocca e il naso liberi e potevo azzardare una respirazione lenta e poco profonda, con un ritmo che mi veniva spontaneo e che mi aiutava a vincere la paura. Un movimento delle braccia, del tutto istintivo, mi fece ruotare su me stesso: guardavo nuovamente la riva, ma ora mi appariva lontana, quasi irraggiungibile.
Continuavo a muovere le gambe nel ritmico movimento del camminare e mi accorsi che mi spostavo lentamente verso terra. Passo dopo passo finalmente sentii di nuovo la sabbia sotto la punta estesa del piede, mi puntellai sulle dita, diedi una leggera spinta, mi spostai in avanti fino a toccare con l’intera pianta del piede. Ero riuscito a tornare.
Arrivai lentamente a riva e solo allora l’adrenalina si impossessò completamente di me: avevo corso un bel rischio, ma ne era valsa la pena. Avevo capito che ci si poteva muovere anche nell’acqua profonda senza necessariamente affogare, anzi, ci si poteva divertire. Cominciai, così, ad apprendere i diversi movimenti del nuoto: la battuta dei piedi, la respirazione, il galleggiamento, le differenti passate di braccia, che mio padre correggeva con l’attenzione di un esperto, amorevole e alquanto divertito istruttore.
Dopo di allora, ogni giorno di mare rappresentava un’occasione per migliorare e aumentare la fiducia nei miei mezzi fino a impadronirmi dei movimenti necessari. Eppure, uno dei principi che mi vennero inculcati nella mente e che lì si radicarono profondamente fu il sacrosanto rispetto del mare e la consapevolezza dell’essere sempre vigile e consapevole della realtà circostante quando ero in mare. Una conoscenza che mi sarebbe servita negli anni a venire.
Così, imparai a nuotare grazie a mio padre che mi spronava per mettermi alla prova e mi dava consigli su come muovermi e respirare, e tutte le altre cose che dovrebbe conoscere un bravo nuotatore. Di fatto, l’acqua ha sempre rappresentato per me un elemento di attrazione, un ambiente nel quale sentivo di potere esercitare la mia voglia di libertà. La consapevolezza di cosa significasse sentirsi senza peso sarebbe stata acquisita anni dopo, quando imparai a usare gli autorespiratori.
Nell’interregno, cioè tra i dodici e i diciannove anni, il nuoto e la pesca in apnea rappresentarono le mie valvole di sfogo, purtroppo limitate al solo periodo delle ferie estive di mio padre. Negli anni ’60, però, il litorale laziale più prossimo alla città divenne per me una meta relativamente abituale non appena la stagione lo permetteva.
Il mio compagno di banco al liceo, nonché all’epoca amico per la pelle, possedeva una splendida Vespa 125 e con quella, almeno una volta alla settimana, scappavamo al mare evitando accuratamente di vivere per un giorno la claustrofobia della classe. Meta delle nostre fughe era la spiaggia di Torvaianica, in corrispondenza di quel tratto di litorale dove, anni dopo, si sarebbe sviluppato il centro abitato di Campo Ascolano. A quei tempi, c’erano solo poche case costruite sulla spiaggia, immediatamente a ridosso della strada litoranea che va da Ostia ad Anzio, e la spiaggia era pulita e sempre libera. Nessuno ci portava i cani a fare passeggiate e bisogni altrimenti vietati sui marciapiedi cittadini, né si vedevano barche lasciate lì per l’inverno o relitti abbandonati a marcire sull’arenile. Di tanto in tanto un tronco d’albero trasportato dalle mareggiate si arenava sulla battigia e lì rimaneva fino a quando una nuova mareggiata non se lo portava via, oppure veniva consumato dal fuoco in qualche notte di festa dei gruppi di giovani che su quei lidi trascorrevano l’estate. Si, era bello stendersi su quella sabbia grigio chiaro e restarsene così a chiacchierare e godersi i primi caldi della primavera.
Non avevamo il costume con noi, né un telo con cui asciugarci, ma questo non ci impediva di fare il bagno e rimanere in acqua fino a sentirci completamente intirizziti a causa della bassa temperatura del mare di aprile. Così ci stendevamo al sole fino a scaldarci, per poi tuffarci nuovamente in mare e godere della sensazione di gelo che sul momento attanagliava le membra e che si scioglieva nuotando. Ricordo che il mio più grande divertimento era stendermi sulle secche di sabbia che si formavano per la risacca a pochi metri dalla riva e mettermi a cercare le telline. Ce n’erano tante, a quei tempi, ed erano grandi. Le prime le tenevo in bocca, poi, man mano che il loro numero aumentava, le infilavo negli slip. Una volta tornato a riva, però, mi rendevo conto che non avrei potuto farci nulla, né, tanto meno, portarle a casa per preparare un sugo per gli spaghetti. Così, invariabilmente, le ributtavo a
mare tra le risate del mio amico Massimo. A volte, invece, ci mettevamo addirittura a studiare, perché, in realtà, non era una fatica farlo e il nostro marinare la scuola non era dovuto alla scarsa voglia di studiare, quanto, piuttosto, al bisogno quasi fisico di sentirci liberi da ogni vincolo.
Un anno, nell’arrivare sulla spiaggia, trovammo una sorpresa che ci rese felici; me soprattutto che già da anni avevo la passione per la pesca subacquea. A un centinaio di metri dal bagnasciuga si ergeva verticale sulla superficie del mare un albero di nave con un fanale e una crocetta dalla quale pendevano i resti su una sartia. Evidentemente, durante una delle forti burrasche invernali, proprio lì era affondato un piccolo peschereccio, andando a posarsi sul fondo ancora in posizione di navigazione. Una vera attrazione per un patito dell’acqua come ero a quell’epoca. Non perdemmo un attimo e ci tuffammo per andare a vedere il relitto. L’acqua era talmente fredda che, al momento del tuffo, sembrava di attraversare una lastra di ghiaccio, ma quella novità ci attraeva troppo e la mia idea era quella di prendere il fanale di posizione come trofeo. Pur essendo riusciti a raggiungere agevolmente la barca, però, ci trovammo costretti a desistere da ogni tentativo di arrampicarci sulle sue strutture e di recuperare un qualche oggetto ricordo. Lo scafo, infatti, era molto danneggiato e senza la possibilità di vedere dove posassimo i piedi rischiavamo di tagliarci ben bene su quei resti sfrangiati e disarticolati. Quanto poi all’arrampicarsi sull’albero per raggiungere il fanale, non se ne parlava nemmeno; quel tronco, infatti, era tanto viscido per le alghe che vi si erano sviluppate sopra che ci sembrò sarebbe stato più facile arrampicarsi sull’albero della cuccagna di qualche fiera di paese. Ci rimase, in ogni caso, la soddisfazione di averci provato e il ricordo di quanto fosse fredda l’acqua quel giorno di fine marzo.
A quanto ricordo, il relitto rimase lì tutta l’estate e parte dell’autunno, anche se sempre più impoverito delle sue parti a vista. L’ultima a sparire fu proprio il fanale di posizione, poi scomparve anche la crocetta e all’inizio dell’inverno non c’era più nulla che alterasse l’uniformità della superficie del mare. Forse una mareggiata aveva finito per squassare quello che rimaneva dello scafo, o forse qualche sua parte ancora si trova in posto, sommersa da un metro di sabbia.
***
Trascorsero molti anni prima che potessi tornare in quel mare. Molte cose erano cambiate, anche l’accesso alla spiaggia non era più lo stesso. Al posto dello stradello ove lasciavamo la Vespa ora c’era una vera strada asfaltata fino al limite della spiaggia, quello definito dalle mura perimetrali delle costruzioni che erano state costruite l’una avvinghiata all’altra a costituire una lunga barriera fino al centro del paese. Il limite naturale sarebbe coinciso con il bordo della strada litoranea, ma questo ormai era stato fagocitato dalle abitazioni di villeggiatura dei romani. Alti muri, per lo più scrostati dalla salsedine, si allineavano senza soluzione di continuità fino alla sponda del canale che originariamente faceva da confine al paese di Torvaianica. Ogni tanto una larga saracinesca stava a indicare il tentativo di realizzare una rimessa per imbarcazioni, ma la sabbia accumulatasi fino a coprirne un terzo dell’altezza denunciava l’abbandono di quel tentativo da un certo numero di anni.
Si prova una sensazione di totale abbandono quando d’inverno si passeggia su quel tratto di spiaggia, ma quando splende il sole e il mare calmo accarezza la battigia con lievi ondine appena mosse dalla brezza di tramontana, si ha l’impressione di essere approdati su un’isola deserta abbandonata dagli uomini e, stranamente, da ogni forma animale a esclusione dei pesci e dei gabbiani. Non si soffre la solitudine in quei momenti. Al contrario, la si apprezza per la possibilità che offre di parlare con se stessi rivivendo e analizzando le proprie esperienze, elaborando e metabolizzando i momenti di gioia e quelli di dolore. Si trova sempre un tronco su cui sedere o una vecchia barca da usare come scomodo, ma utile, sedile. Allora lo sguardo vaga lontano a scrutare l’orizzonte e abbandona la visione troppo terrena e limitante delle case che chiudono la spiaggia e dei tanti rifiuti
che parlano di frequentazione umana. Si entra in quello stato di grazia durante il quale si vive di ricordi, ma solo di quelli piacevoli perché quelli brutti sarebbero troppo dolorosi. Un volto di donna prende lentamente forma nella mente. È giovane e bella, quella donna. È l’espressione stessa dell’amore e della passione. La sua immagine è inebriante così come lo è il profumo della sua pelle dopo l’amore. È tanto forte quest’immagine da fuoriuscire dal ricordo e spandersi nell’aria avvolgendoti in un caldo abbraccio, quasi fosse una presenza reale e non la proiezione di un sopito desiderio.
Una scheggia di luce che esplode sul mare attira l’attenzione e interrompe la magia del ricordo; le immagini svaniscono e le lievi ondulazioni della sabbia ritrovano forma e consistenza. La visione svanisce e al suo posto si materializza il profilo di una barca. È ancora lontana, ma se ne distinguono il blu intenso della fiancata e le due figure che sono a bordo. Una ha una maglia del colore del corallo, e forse è anche vecchia e piena di buchi proprio come un vecchio corallo attaccato dalla carie. La barca scivola veloce sul mare calmo d’inverno e dietro di sé lascia una scia bianca. Presto raggiungerà la riva. Invece si arresta al largo, all’altezza di una boa, ma il motore resta acceso. Quello con la maglia rosso corallo recupera un cavo e lo fa passare sopra il vano motore da poppa a prua. L’altro rimane al timone e innesta la marcia, mentre due ruote vengono calate ai lati della barca, ben agganciate al trincarino. Seguo con curiosità i movimenti dei due uomini e mi rendo conto che sulla riva sta andando in tensione un cavo di acciaio legato a un’ancora profondamente infissa nel terreno quasi al limite superiore della spiaggia. Lungo quel cavo avanza l’imbarcazione ora parzialmente sostenuta dalle ruote. Quando la barca si arena, maglia rossa balza in acqua e va a prendere le falanghe da metter sotto la chiglia man mano che la barca avanza trascinata dalla forza del suo stesso motore. Ora la barca è ferma e l’uomo rimasto sopra, un vecchio dal fisico asciutto e una barba incolta che gli contorna la mascella, ripone la barra del timone e inizia a scaricare il pescato. Il frutto di quella giornata di pesca è stivato in grandi secchi che il vecchio passa con calma al giovane, il quale li sistema su un telo di plastica che poco prima aveva steso sulla sabbia.
I secchi sono pieni fin quasi a traboccare; in uno c’è minutaglia mista e di pezzatura che andrebbe bene per una zuppa o per una frittura. In un secondo, dei bei polpi tentano di scalare le lisce pareti per tornare al vicino mare; nel terzo si dibattono negli ultimi spasimi di vita due bei muggini. I pescatori, unici frequentatori invernali di quei lidi, sono tornati alla loro base dopo aver recuperato le reti da posta lasciate sulle Secche di Tor Paterno, appena qualche centinaio di metri più a nord, immediatamente di fronte alla tenuta di Castel Porziano.
Di colpo la spiaggia si anima. Dai vicoli in mezzo alle case spuntano a coppie uomini e donne con buste di plastica strette in mano. Fanno a gara per arrivare primi alla barca. Chiedono, guardano, indicano, contrattano e, dopo un rapido scambio, tornano all’ombra dei loro vicoli con le buste piene e l’animo felice. I due pescatori contano il guadagno, sciacquano in mare i secchi ormai vuoti e li riempiono nuovamente con altri pesci che avevano lasciato in barca: orate, mormore e saraghi, più grandi e più belli di quelli venduti prima. Questi li venderanno con maggior profitto nella pescheria aperta all’angolo della strada e gestita dalla figlia del vecchio, nonché moglie dell’uomo con la maglia rosso corallo. Si allontanano lentamente, silenziosi e sereni con il loro prezioso carico.
La spiaggia, ora, è nuovamente deserta.
Solo una barca dalle fiancate blu interrompe la visuale verso l’infinito dell’orizzonte.
 Zoomma Dove scoprire nuovi interessi
Zoomma Dove scoprire nuovi interessi